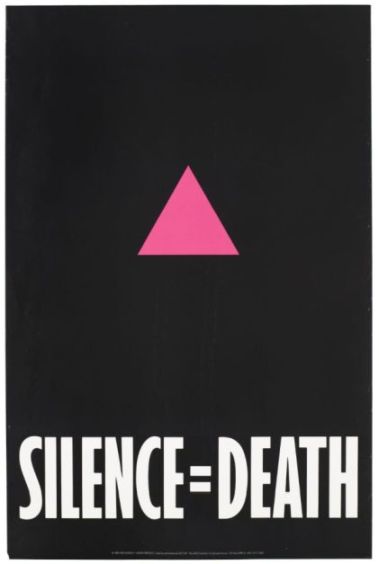Pubblichiamo la seconda parte di un’inchiesta collettiva sui temi della salute e della sanità a due anni ormai dall’irruzione sulla scena mondiale della pandemia di covid-19 (qui puoi leggere la prima). Anche questa volta vogliamo offrire un punto di vista autonomo, di parte, che consideriamo sempre più necessario di fronte a quanto sta accadendo: nell’astrusa gestione governativa, nelle pressioni dei grandi concentrati di potere e di capitale, nella sarabanda mediatica, persino nella grandi proteste di piazza, la salute ai tempi della pandemia è stata infatti la grande vittima, nonostante la retorica martellante che la voleva al centro di questi due anni dannati.
Il secondo contributo che pubblichiamo per questa inchiesta è un‘intervista ad una sanitaria, specializzata in medicina generale, che attualmente lavora in guardia medica e USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziali) di Trieste e Provincia. Durante la sua formazione si è occupata anche di microaree e salute territoriale.
Buona lettura!
1.Cosa sono le USCA e come sono nate nel nostro territorio?
A Trieste le USCA [Unità Speciali di Continuità Assistenziale, ndr] sono nate fondamentalmente su un’autorganizzazione. A differenza di altri luoghi in Regione e in Italia che hanno aspettato la formalizzazione dopo l’istituzione del decreto, a Trieste sono state attivate quasi immediatamente le guardie mediche per mettersi a disposizione nel neonato servizio USCA. La decisione del governo era un punto di partenza, però le modalità di attuazione erano da decidere su base territoriale, così ci sono state declinazioni diverse a seconda dell’azienda sanitaria in questione.
Sul momento è stato un fatto positivo: la pandemia era già una cosa reale, ma il carrozzone burocratico era ovviamente in ritardo. A Trieste, dove in un primo momento si era reagito abbastanza velocemente, la realtà purtroppo è rimasta sempre quella. Non è mai stato fatto un bando di assunzione per le guardie mediche coinvolte nell’USCA. Sono state prese in maniera abbastanza informale delle persone che avevano già il titolo di medico di famiglia o che stavano frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale. Quest’ultimi sono stati esentati dai tirocini per poter essere inseriti nel servizio.
2. Come hanno funzionato le USCA durante i primi mesi della crisi?
A Trieste e provincia non c’è mai stata una vera e propria organizzazione. Il servizio è rimasto a chiamata del cittadino.
Per come è strutturato, non c’è la possibilità di una presa in carico del paziente, che non viene dunque richiamato o ricontrallato nel tempo, a meno che non sia lui stesso a rimettersi in contatto con l’USCA o che il singolo medico prenda iniziativa individualmente. Di fatto io e altri colleghi abbiamo seguito diversi casi, ma questo è avvenuto esclusivamente su spinta volontaria, mai in un modo sistematico.
In altre aziende sanitarie, invece, l’USCA ha svolto visite programmate su indicazione del Dipartimento di Prevenzione o del Medico di Famiglia.
Dunque i cittadini hanno avuto come riferimento un numero verde a cui rispondeva un infermiere che, svolto un triage telefonico per eventuali urgenze di competenza diretta del 112, rimandava le chiamate a noi o al loro medico di base. Da una parte, i medici di famiglia a Trieste, al di là di qualche gruppo particolare, non hanno un funzionamento esemplare (e negli ultimi decenni non vi è stata alcuna riorganizzazione della medicina generale locale). Dall’altra, si sono trovati totalmente sovvracarichi. Nelle prime settimane non c’erano nemmeno DPI [Dispositivi di Protezione Individuale, tra cui mascherine e guanti, ndr] per tutti. Tutto questo ha fatto sì che la valutazione clinica territoriale delle persone fosse interamente affidata alle USCA.
Dopo un po’ la cosa si è assestata. Alcuni medici di famiglia hanno iniziato a visitare i loro pazienti e a rivolgersi a noi solo in caso di situazione cliniche indifferibili. Altri medici invece hanno continuato a lasciare alle USCA il lavoro di visita.
Questo, insieme al malfunzionamento del Dipartimento di Prevenzione, ha fatto ricadere sull’USCA una notevole mole di lavoro. Non solo le questioni correlate alla clinica, ma anche quelle più burocratiche: interrogativi sui contatti sospetti, informazioni sui certificati di quarantena, ecc. Tutte questioni teoricamente affidate al Dipartimento di Prevenzione, su cui però in quasi due anni di pandemia non sono mai riusciti a dare risposte puntuali e veloci.
3. Come svolgete il vostro lavoro attualmente? È migliorata la qualità del vostro servizio col passare delle ondate?
Come USCA siamo ancora attivi. Noi richiamiamo la persona malata [dopo che essa ha contattato l’USCA attraverso il numero verde, ndr], valutiamo le condizioni cliniche al telefono e se c’è bisogno andiamo a visitarli. Come strumenti diagnostici abbiamo a disposizione un saturimetro, un fonendoscopio e per un periodo abbiamo avuto anche un ecografo, ma lo abbiamo utilizzato molto poco perchè la formazione in medicina generale – almeno in questa regione – non prevede una formazione adeguata su tale metodica diagnostica.
Per altri interventi (esami del sangue, medicazioni, reidratazione endovenosa, ecc) è sempre stato attivo il servizio infermieristico del distretto.
Per eseguire accertamenti o valutazioni specialistiche – anche non strettamente legate al covid –, se la persona è positiva, deve accedere al Pronto Soccorso.
Nel tempo il nostro servizio è rimasto invariato e, credo che la qualità, aldilà degli strumenti a nostra disposizione, sia dipesa molto dalle richieste: nei momenti critici abbiamo dovuto iperselezionare le visite domiciliari, rimandando direttamente al Pronto Soccorso i casi che apparivano già gravi al telefono e tralasciando casi in cui non vi erano reali necessità cliniche (ma in cui un visita sarebbe potuta essere rassicurante per la persona o il suo entourage).
La situazione è comunque sempre molto fluttuante. Ora, almeno dal punto di vista clinico, la situazione è meno grave, il saturimetro è ormai uno strumento diffusissimo e la diagnosi di positività è precoce. All’inizio della crisi capitava di avere persone con febbre da 10 giorni che non avevano eseguito un tampone. Tante persone ci contattavano tramite il numero verde e ci dicevano che avevano sintomi, ma noi come USCA non potevamo programmare un tampone, soltanto fare una segnalazione – tramite mail – al Dipartimento di Prevenzione che, con grande lentezza, tamponava il paziente e solo una volta accertata la positività faceva partire il contact tracing. Perciò noi consigliavamo alle persone che avevano avuto dei contatti stretti di stare a casa nel frattempo, chiedendogli di invertarsi un modo per farlo, considerando il grosso problema del dover giustificare una assenza lavorativa (senza essere malati e senza essere stati “riconosciuti” ufficialmente come contatti stretti).
4. Cosa rappresenta il COVID-19 per un medico che lavora nel territorio?
A livello clinico, la malattia è grave. Noi, come guardie mediche, siamo abituati a gestire i picchi di influenza, ma il covid non è paragonabile. La principale differenza è che il covid colpisce gravemente anche soggetti abbastanza giovani, in termini relativi, come quelli appartanenenti alla fascia 45-55. La gravità in questi casi dipende spesso del quadro pregresso (obesità, diabete, altre patologie) e perciò, secondo me, oggi, dopo due anni di pandemia, le riflessioni dovrebbero essere incentrate di più su questi aspetti, ovvero sulla società e gli stili di vita dominanti.
Si tratta di una malattia che è cambiata nel tempo, così come la nostra percezione di essa. È una patologia abbastanza “stronzetta”, perché dà, nella maggior parte dei casi, un quadro respiratorio del quale non è facile accorgersi in un primo momento. Secondo me, se non sei una persona sportiva o abituata a sentire la tua respirazione, non è facile rendersi conto precocemente che c’è un problema. E così, i casi più brutti che abbiamo assistito a casa erano quelli di persone che ti dicevano di star bene mentre respiravano già con le branchie.
Nell’estremo opposto ho incontrato delle persone, gente giovane e sana che, nonostante cercassimo di tranquillizzarli spiegandoli che il loro caso non era grave, entravano in un loop di piena paranoia. Questo succedeva anche a chi disponeva di risorse (culturali, sociali, famigliari, ecc) per resistere all’isolamento. Tante persone senza particolari problemi clinici ci richiamavano ogni giorno. Ci contattavano perché erano soli a casa o perché si sentivano in colpa di aver contagiato familiari anziani. E tu non avevi nessuno strumento per aiutarli. Nei momenti peggiori, in cui visitavo gente anche fuori dall’orario di lavoro, ho fatto molte visite “di cortesia“, anche solo per placare l’ansia delle persone. Molti finivano per andare in pronto soccorso senza motivo clinico e, senza accesso in ospedale, non c’era neppure la possibilità di farli prendere in carico dai servizi psichiatrici.
Quindi secondo me il covid è una malattia doppia: da una parte, la malattia subdola che ti prende e che può mettere in seria difficoltà il tuo sistema respiratorio e, dall’altra, la paranoia di malattia, anche se non è grave. Purtroppo, tranne in rari momenti, non c’è mai stata una rete di psicologi di supporto, al massimo, in alcuni momenti, ci sono stati dei gruppi di psicologi volontari, ma poca roba.
5. Come è stata gestita la crisi nelle case di riposo e qual è stato il vostro ruolo in quelle situazioni?
In un primo momento è stato un grande delirio: come USCA andavamo nelle case di riposo su chiamata per un singolo caso e, ovviamente, ci trovavamo a valutare numerosi casi. Dopo un po’ abbiamo deciso di mettere un nostro collega ad hoc per quel servizio, ma in ogni caso tutto è stato sempre abbastanza informale.
Ci sono stati tanti morti nelle case di riposo. Per me questo è dovuto alla gravità della patologia di per sé e alle condizioni di salute, già precacarie prima dell’infenzione di covid. A Trieste non attribuirei queste morti alla strategia di non ricoverarli in ospedale [effettivamente praticata altrove, ndr]. Nella mia pratica, la scelta di non ricoverare è sempre stata legata ad una valutazione della volontà della persona e della sua rete famigliare (quando presente). Altri fattori importanti per prendere questa decisione erano la tipologia di struttura in cui si trovava la persona e le cure aggiuntive di cui avrebbe potuto beneficiare in caso di ricovero. Nella realtà è successo di tutto: persone che io non avrei ricoverato lo sono state e viceversa.
6. Invece qual è stato il vostro rapporto con le persone anziane che abitavano in casa propria?
Trieste è una città con molti anziani. E la solitudine di molte di queste persone è una realtà. Aldilà dei casi respiratori gravi, in questa fascia di popolazione molte problematiche sono state legate all‘assistenza. Non avevano una vera e propria rete familiare – o questa si era sgretolata – e la perdita di autonomia legata al covid gli aveva creato problemi di disidratazione o di alimentazione. C’era la possibilità di attivare un infermiere di distretto, ma sono pochi, e quindi spesso abbiamo preferito ricoverarli. Sul territorio sono state attivate strutture intermedie a bassa intensità di cura per la presa in carico di queste persone, ma spesso la valutazione di questi casi è avvenuta “in urgenza” da parte delle USCA, e ha implicato il ricovero in ospedale e il successivo trasferimento in struttura ad hoc.
7. Cosa ci puoi dire sul ruolo del Dipartimento di Prevenzione nella crisi?
Come USCA, dal Dipartimento non abbiamo avuto molte notizie, né linee guida, né grande cooperazione. Sono da sempre in difficoltà e, dopo che gli sono state affidate le decisioni centrali riguardo la pandemia, non sono stati rafforzati in modo adeguato e strutturale: hanno assunto sempre con contratti brevi tutto quel mondo sanitario “nel limbo”. Per questo, e per l’elevatissimo numero di chiamate che ricevono, sono stati sempre inefficaci; il contact tracing ha sempre funzionato malissimo. A novembre, poi, quando molti sanitari sono rientrati nelle scuole di specializzazione, il Dipartimento è veramente crollato.
8. Come è stata adattata la sanità triestina, da un punto di vista generale, alla pandemia?
Non è stata effettuata una vera e propria riorganizzazione dei servizi, né durante la prima ondata né più avanti. In due anni non sono riusciti a pensare ad un’organizzazione efficace. Sono stati creati gruppi di coordinamento tra i vertici sanitari, ma con un’organizzazione del territorio imbarazzante.
Hanno semplicemente potenziato qua e là alcuni servizi già esistenti, senza creare una vera cooperazione tra le varie figure coinvolte. E anzi, alcuni servizi esistenti che in una situazione del genere potevano essere essenziali, come le microaree, sono state chiusi all’inizio della pandemia. Per quello che riguarda i medici di base,per quanto ne so io, non si è nemmeno pensato di coinvolgerli in una riorganizzazione.
È difficle da spiegare, perché non ne ho sicuramente la visione d’insieme e per farmi capire dovrei fare mille esempi. Il mio vissuto, e credo quello di molti altri colleghi, è che molti malfunzionamenti e e “disservizi” hanno implicato un sovraccarico di lavoro per tutti e sarebbero stati risolvibili con una maggior cordinazione tra i vari attori coinvolti.
9. Cosa ti sembra che potrebbe rendere migliore la sanità territoriale triestina, dal punto di vista della presa in carico e cura del paziente?
In una città come Trieste, secondo me, sarebbe stato sufficiente continuare nella direzione già avviata, ovvero la territorializzazione dei servizi.
La forza dei distretti a Trieste era una realtà. Io, venendo da un’altra città, conoscevo i distretti come pure entità amministrative, non erano punti di riferimento per la salute delle persone. A Trieste invece già da tempo l’azienda territoriale era scissa dall’azienda ospedaliera e ciò aveva generato una buona rete di assistenza primaria. Purtroppo, con le riforme degli ultimi anni, ci sono state notevoli marce indietro e, come del resto in tutta l’Italia, si è favorito il privato investendo sempre meno sulla struttura pubblica.
Come USCA avremmo lavorato molto meglio se avessimo avuto una popolazione di riferimento precisa, invece che ricevere persone da un numero unico [il numero verde, ndr], che si è preso in carico tutta la popolazione.
10. Invece qual è stato il ruolo delle microaree durante la pandemia?
Le microaree erano un bellissimo progetto sociosaniatario orientato alla salute della popolazione, apparentemente visionario per i tempi in cui furono pensate [nel 2005, su spinta dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Trieste, il Comune e l’ATER, ndr]. Per la prima volta si mettevano degli operatori, uno per ogni microarea, in 10 zone svantaggiate, allo scopo di valutare cosa fare in termini di salute. La grande novità consisteva nel fatto che non si istituiva un servizio di cui il cittadino poteva usufruire, ma si andava a conoscere un territorio per comprendere quali fossero gli ostacoli che impedivano a quelle persone di fare gli stessi percorsi di salute di persone che vivono in altri quartieri.
Per quanto posso averci capito io, il progetto è stato inizialmente possibile perché al tempo c’era Rotelli a capo della sanità, e poi è rimasto in piedi perché non dava fastidio nel budget complessivo.
Da un po’ di tempo non frequento le micrearee e non mi confronto con le persone che ci lavorano, ma l’impressione è che negli anni siano state svalorizzate, perdendo il potenziale trasformativo che rappresentavano. La mia impressione è che il servizio sia stato ridotto a quello che potrebbe essere il ruolo di un infermiere di comunità. Rimane comunque un servizio utile, ma rappresenta un passo indietro rispetto al progetto iniziale, che era prima di tutto di carattere sociale e guardava al quartiere di riferimento nel complesso.
In tempi di pandemia le microaree avrebbero potuto intervenire a partire da una conoscenza reale delle fragilità, cliniche e sociali, del territorio. Ad esempio, quando lo Stato ha detto alla popolazione “state a casa”, generando ulteriori disagi in tante persone, la microarea sarebbe dovuta essere sia un punto cruciale d’informazione per capire come affrontare l’emergenza in quei quartieri – fragili e come tale a maggior rischio – sia una risorsa per dare un supporto reale a quella parte di popolazione. Invece sono rimaste del tutto marginali, anche perché le microaree hanno utilizzato spesso della forza lavoro precaria, tipo persone che facevano il servizio civile o anziani del quartiere, e questi hanno ovviamente interrotto il loro contributo con l’inizio dell’emergenza.
Il problema è strutturale: il servizio sanitario da anni è sottofinanziato e la logica prevalente è quella aziendale.
11. Come pensi dovrebbe funzionare la medicina territoriale in Italia, per essere veramente efficace?
In italiano ci sono molti termini (medicina di comunità, cure primarie, assistenza primaria, ecc) che possono indicare modelli simili ma anche molto diversi, a seconda del contesto in cui sono applicati.
Per me, quando si parla di medicina territoriale, si dovrebbe far riferimento a quello che in inglese viene definito Primary Health Care, un paradigma formulato e descritto per la prima volta nel 1978 e basato sul concetto dei determinanti, sanitari e non, di salute. È un modello a cipolla, dove dai fattori genetici passi al lavoro, alla casa, all’economia, alla famiglia, all’ambiente. Un approccio globale alla salute del singolo e della collettività, esito della collaborazione attiva tra vari settori della società e della partecipazione di tutta la comunità.
In pratica, i professionisti della salute possono anche dirti di camminare un’ora al giorno, di mangiare bene e di non stressarti, ma se poi non riesci a farlo per le tue condizioni sociali o economiche, vengono fuori tutta una serie di malattie croniche. E il covid l’ha subìto prima di tutto quella parte di popolazione più esposta.
Per attuare un modello di Primary Health Care non è sufficiente riformare la medicina di famiglia o istituire l’infermiere di comunità. Bisogna sviluppare un sistema che sia interessato a “fare salute” e non solo sanità. Poi la declinazione pragmatica dipende dal territorio specifico in cui interviene, un conto è stare in Veneto e un altro stare a Trieste. La pratica dipende dal territorio e dalla popolazione che ti prendi in carico.
12. Si è parlato molto del ruolo dei medici di famiglia durante la pandemia, qual è la tua visione a riguardo?
Innazitutto, credo che l‘assistenza primaria debba essere pubblica, perciò considero un problema il fatto che in Italia il medico di famiglia sia un privato convenzionato. Questo inquadramento professionale ha determinato lo sviluppo di una figura di medico “solista“ che, nonostante alcune riforme, ancora oggi è tale, soprattutto a Trieste.
Potremmo parlare per delle ore di quali sono attualemente le criticità (e ci sono infiniti studi e professionisti che si occupano di questo argomento), ma mi limiterò ad un esempio: la scelta del medico di famiglia in un Comune è lasciata al singolo cittadino – libertà sempre più risicata vista la carenza di medici. Può un servizio sanitario sviluppare una rete territoriale efficace se il distretto sanitario, a cui fa riferimento una parte della popolazione, ha potenzialmente come interlocutore tutti i medici di famiglia del comune di Trieste?
Per me, in gran parte di questo Paese, abbiamo un modello ottocentesco in cui limiti, già chiari prima, sono diventati evidenti con la pandemia.
Esistono modelli differenti, ad esempio quello portoghese, dove hai una casa della salute di riferimento a seconda di dove abiti; non un medico di riferimento, ma proprio una “casa”, dove entri, esprimi un problema e viene individuato il percorso più adatto per la tua situazione.
13. Qual è stato il tuo approccio terapeutico a domicilio inizialmente e com’è adesso dopo due anni di visite domiciliari?
Sotto il profilo delle terapie, in una prima fase, quando le linee guide erano assenti, andavamo a tentativi. Suona brutto ma è così. Per fare un esempio, inizialmente si pensava che l’azitromicina – un antibiotico – potesse aiutare, ma poi nessuno studio ne ha provato l’efficacia.
Nel primo periodo, nei casi di persone che sviluppavano la polmonite interstiziale ma che non richiedevano il ricovero, abbiamo prescritto prevalentemente cortisone e antibiotico. Nei casi in cui era necesario, anche l’ossigenoterapia.
Ad oggi la situazione è un po’ cambiata: i protocolli indicano l’introduzione del cortisone solo in soggetti ospedalizzati che necessitano ossigeno. Per quanto riguarda quest’ultimo, con l’emergenza era stata creata la possibilità di attivazione dell’ossigeno liquido (tramite accordo – immagino nazionale – con la ditta Vivisol). Si trattava di una novità, perché tale attivazione è sempre stata riservata allo specialista pneumologo. Dallo scorso luglio, senza attivazione ospedaliera, non è più possibile fornire ossigino liquido. Quindi se vuoi stare a casa e hai bisogno di ossigeno, o c’è una persona della tua rete che ti va a prendere regolarmente le bombole di ossigeno in farmacia oppure è impossibile farlo (le bombole di ossigeno gassoso hanno una durata limitata, indicativamente 24 ore).
In più, circa da aprile 2021, c’è un protocollo per la terapia con gli anticorpi monoclonali praticata in day hospital nel reparto delle malattie infettive, a cui sono candidabili certi target di popolazione.
L’azienda sanitaria non ci ha mai indirizzato verso l’utilizzo di nessuna terapia, rimandandoci indirettamente a seguire le linee guida dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Ad un certo punto, l’azienda sanitaria ha creato un protocollo per somministrare l’idrossiclorochina [farmaco antimalarico usato anche contro altre patologie, ndr], ma, a domicilio, non è mai stato applicato. Non c’erano evidenze scientifiche e la gestione sul territorio ci è sembrata impraticabile (esecuzione di esami ed elettrocardiogramma prima della somministrazione, evidente necessità di monitoraggio nel tempo delle persone, ecc). Nei reparti ospedalieri delle malattie infettive, invece, l’idrossiclorochina è stata utilizzata (oggi non più).
Nella pratica, non c’è mai stata una riunione per coordinarci fra i diversi servizi (infettivologi, USCA, medici di famiglia, pronto soccorso), per concordare assieme un protocollo di assistenza e cura. Da parte nostra, i 15-20 medici che facciamo parte dell’USCA ci siamo sempre confrontati informalmente rispetto alle evidenze prodotte e la nostra pratica, in particolare su necessità di ospedalizzare, uso di antibiotici e cortisone.
Io oggi continuerei a somministrare cortisone a domicilio in certi casi selezionati (che per brevità e specificità di esposizione non descrivo) ma, per quanto ne so, non sono stati organizzati studi a tal proposito. La mia è un’affermazione non fondata ma, nella pratica, abbiamo avuto diversi casi di persone che, dopo la somministrazione del cortisone, sono migliorate e sono rimaste a casa. Il problema è che rimane il dubbio se sia stato l’effetto del cortisone o il naturale decorso della malattia in quelle persone.
14. E cosa ne pensi delle cosiddette “terapie domiciliari precoci”?
Non so bene cosa dire di questi gruppi che hanno applicato terapie domiciliari precoci. Se da una parte mi risuonano le parole, senza troppi ragionamenti, di tanti miei colleghi che si scagliano contro i novax e contro queste cure “alternative“, dall’altra parte ho molte perplessità, sia cliniche che gestionali. Sono impressioni su aspetti colti durante il mio lavoro, non ho un quadro completo sulla rete delle cosidette “cure domiciliari precoci” che ha operato a Trieste.
I dubbi clinici riguardano prevalentemente la somministrazione di antibiotici e cortisone dal primo giorno di malattia. L’infezione è virale e quindi non vedo il razionale di somministrare indiscriminatamente l’ antibiotico (che agisce su batteri). Il cortisone è un immunosoppressore e quindi nelle fasi iniziali della malattia può essere dannoso.
Dal punto di vista gestionale, oltre al fatto che abbiamo avuto notizie di cifre imbarazzanti per visite a domicilio, la poca chiarezza delle loro prescrizioni – eseguite come medici privati e quindi a carico del cittadino – ha generato un ulteriore sovraccarico di telefonate per i medici di famiglia e le USCA da parte delle persone che richiedevano la prescrizione di queste terapie a carico del servizio sanitario (tralascio il discorso della responsabilità prescrittiva).
Poi c’è il discorso che alcune delle persone che si sono affidate alle “cure domiciliari” hanno comunque avuto un decorso sfavorevole e sono comunque “ricadute” sul nostro servizio. È difficile fare un discorso logico perché non ho una casistica ed è vero che noi intercettiamo prevalentemente quelli che sono andati male, quindi il nostro campione forse non è molto rappresentativo.
Bisogna comunque riconoscere che alcune persone sono state contente perché questi medici hanno probabilmente garantito una presa in carico più reale delle persone, anche se spesso solo al telefono.
15. Qual è stata la politica relativa ai ricoveri in ospedale?
Bisogna ammettere che come USCA abbiamo subìto pressioni per non ricoverare i pazienti. Questo non vuol dire che ci sia mai stata indicazione di non ricoverare, ma il contesto – ospedale al collaso e altri fattori – sicuramente ha influenzato le pratiche. Così all’inizio abbiamo provato a tenere tanta gente a casa. Oggi si ospedalizza più spesso, anche casi un po’ borderline che prima avremmo cercato di tenere a casa.
16. Hai detto che dopo due anni il quadro covid in generale è meno grave: questo è dovuto ai vaccini, agli anticorpi, perché abbiamo imparato a gestirlo come malattia, perché le varianti sono meno gravi?
Non direi che abbiamo imparato a gestirlo. Lavoriamo nell’orizzonte in cui sappiamo che è più probabile che siano i non vaccinati a finire ospedalizzati. Non saprei, però facendo un raffronto rispetto a dicembre del 2020, oggi facciamo forse un numero minore di visite; come telefonate invece siamo sempre lì. Quello che sicuramente è cambiato è che prima c’erano molti più casi domiciliari tosti.
17. E quindi cosa ne pensi di questi vaccini?
Penso che siano un farmaco che, come gli anticorpi monoclonali, è giusto provare. Fidandosi degli studi fatti, sembra la strategia clinica migliore.
Poi come sia stata gestita la vaccinazione, anche politicamente, è il grosso problema. È l’unica cosa che è stata fatta a livello nazionale e gli è stata data un ruolo forse esagerato. Perché tantissime altre cose non sono state fatte.
Poi certo, il vaccino è business, ed è evidente che se non vaccini tutta la popolazione mondiale sarà sempre un lavoro parziale, che ricade poi nei territori. L’esempio più facile è Monfalcone, dove Fincantieri vive di migranti: economia globale, vaccinazione nazionale?
Con le giuste proporzioni, lo paragono al vaccino dell’influenza, un altro farmaco su cui si spendono miliardi, perché effettivamente riduce ospedalizzazioni e morti.
Ci siamo chiesti – come popolazione – se questi soldi non si potrebbero spendere in medicina di comunità, avendo forse risultati migliori. Ma qui c’entra Big Pharma, una programmazione sanitaria a lungo termine – che non si vede da molto tempo –, una valorizzazione della sanità pubblica e della Primary Health Care,ecc
18. Dopo due anni di pandemia, ora come ora cosa servirebbe? Più vaccinazione? Più terapie intensive? Più USCA? Più medici di famiglia?
Per come è strutturato attualmente il sistema a Trieste, il grosso della falla è il contact tracing e la presa in carico delle persone, quindi servirebbe più gente che lavori nel Dipartimento di Prevenzione. Ormai la maggior parte delle persone hanno già avuto il covid o sono vaccinate, quindi non stanno particolarmente male, ma vanno in follia per questioni burocratiche: il discorso delle quarantene, le tempistiche dei tamponi di uscita, la convivenza con familiari in isolamento, ecc. Adesso come adesso, il grosso della questione riguarda questo genere di problemi, che ricadono appunto sul Dipartimento di Prevenzione.
Inoltre, dalla mia prospettiva ovvero un servizio che in pochi giorni è stato investito da diverse centinaia di telefenote, serve trovare una strategia di comunicazione efficace, con informazioni chiare e puntuali ai cittadini.
19. Per quanto riguarda i percorsi di salute dei pazienti non covid, com’è andata la situazione?
L’impressione che ho è che, all’interno del quadro già fortemente critico degli ultimi anni, molto si stia trasferendo sulla sanità privata. Molti casi, soprattutto “non gravi“, oggi come oggi, sono assolutamente rimandati alla sanità privata. Tanti nemmeno provano a prenotare nel pubblico.
Questo era un fenomeno che già esisteva e che con la pandemia si è rafforzato. Il sistema statale è allo scatafascio, negli anni non si è investito, e anzi, sono state ridotte le risorse proprio quando la richiesta aumentava.
Vedi i medici di famiglia in questa città: erano in soprannumero rispetto alla popolazione, e quindi hanno bloccato il turnover. Io sono entrata in guardia medica a Trieste e mi sono trovata colleghi che aspettavano un posto da 7 anni. Adesso c’è carenza da tutte le parti. È un sistema che non programma, che non ha una visione a 10 anni.
C’è quindi un vuoto, lasciato dalla sanità statale. E nel vuoto, entra il privato.
20. Considerando un po’ tutti i discorsi fatti finora, non vedi il rischio che la sanità diventi sempre di più un sistema di controllo (tramite tracciamento, protocolli, isolamento) e burocratico, e sempre meno un sistema orientato alla salute? Per la sensibilità che abbiamo noi, riteniamo che tracciamenti e altri strumenti possano essere in tanti casi degli approcci giusti di salute collettiva, però poi le applicazioni che vediamo nella nostra società finiscono per essere delle forme sempre più alienanti nei confronti delle persone, che si trovano in balia di queste entità burocratiche che le governano.
Quando prima ho detto che il Dipartimento di Prevenzione dovrebbe essere potenziato non intendevo dargli “più potere”, ma metterlo nelle condizioni di essere punto di riferimento, come era stato pensato inzialmente. Se ci fossero più persone impegnate in questa rete di monitoraggio e prevenzione, il servizio sarebbe molto più utile per le persone. Adesso succede il contrario: le persone vengono “catturate” nella rete, che tutto sommato offre un disservizio, e quindi è ovvio che si crea rabbia sociale.
Per come ragiono io, tante delle misure, tutto sommato, sono sensate da un punto di vista clinico: sei sintomatico, sei positivo, i tuoi contatti dovrebbero stare in isolamento. Non si sono però create misure adeguate perché tali regole, a questo punto, siano realmente sopportabili e supportabili nella società. Un esempio semplice credo siano i tamponi: troppo spesso le persone hanno dovuto farli a pagamento.
21. Infine, come vedi il futuro della pandemia?
Io spero che diventi come l’influenza. La spagnola è stata una malattia molto forte, ma poi ci abbiamo convissuto. Per parlare di questo dovrei sapere più storia della medicina, però nella mia formazione non è previsto che conosca così bene le basi del mio sapere.
Dal punto di vista sanitario, ci sarebbero molte cose che potremmo imparare da questa pandemia. Evidentemente questa non è la priorità.