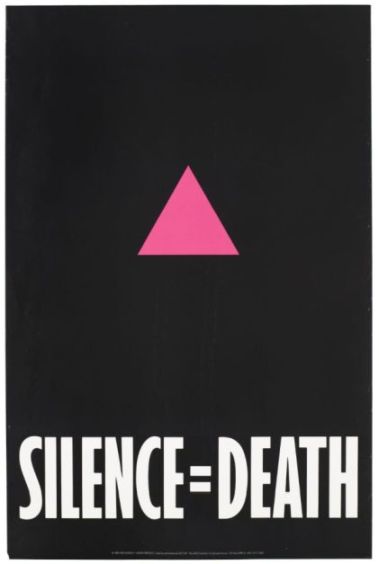Pubblichiamo la prima parte di un’inchiesta collettiva sui temi della salute e della sanità a due anni ormai dall’irruzione sulla scena mondiale della pandemia. Un punto di vista autonomo, di parte, è sempre più necessario di fronte a quanto sta accadendo: nell’astrusa gestione governativa, nelle pressioni dei grandi concentrati di potere e di capitale, nella sarabanda mediatica, persino nella grandi proteste di piazza, la salute ai tempi della pandemia è stata infatti la grande vittima, nonostante la retorica martellante che la voleva al centro di questi due anni dannati.
Il primo contributo che pubblichiamo è una testimonianza ragionata nell’Odissea di Asugi, tra tracciamenti mancati, sviamenti, bollettini di guerra e abbandono (economico, sanitario, sociale).
L’attesa
Questo piccolo reportage nasce dall’attesa.
Alcune delle persone che lo hanno pensato sono, infatti, precipitate da poco nella quarantena o nell’autoisolamento (oppure ne sono appena uscite) e stanno sperimentando da vicino quella sensazione di sospensione che pervade chiunque sia stato costretto alla “Odissea di ASUGI” [1], come l’abbiamo presto ribattezzata.
Io sono fra quelle.
Mentre scrivo, ragiono sul fatto che la fisiologica preoccupazione per le conseguenze di aver contratto questo maledetto virus e per le condizioni di salute mie, condizioni fortunatamente ottime, e delle persone a me vicine e che potrei aver contagiato, sono tutte sensazioni che sono sparite rapidamente, sono state risolte, anzi, grazie alla presenza di una rete capace di rispondere con efficienza alle ansie che mi avevano colto nelle prime ore della malattia.
L’attesa ha sostituito tutte queste sensazioni.
Nel frattempo, isolato nel piccolo appartamento di 40 metri quadri che abito, di solito, con il mio compagno, scambio link e messaggi su Telegram con le altre persone parte della rete di cui sopra, specialmente con quelle che vivono ora la mia stessa situazione.
Discutiamo in particolare di alcuni articoli, usciti sulla stampa locale negli ultimi giorni, che ammettono candidamente l’integrale venir meno di ogni pratica di tracciamento per oltre 2.700 casi nel solo Friuli Venezia Giulia [2].
Il pezzo fa il paio con un’intervista alla dottoressa Ariella Breda, responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUGI, comparsa su Il Piccolo del 10 novembre [3]. Qui, uno dei pezzi grossi della sanità nostrana, dopo una rapida stoccata ai Nemici Di Sempre (“I no vax positivi, quando li chiamiamo, spesso hanno un atteggiamento più polemico […] ma poi, tutto sommato, constatiamo che perdono un po’ della voglia di protestare“), puntava il dito contro un nuovo colpevole, granello di sabbia in quello che parrebbe il meccanismo altrimenti ben oleato messo in piedi dalle Forze del Bene contro la Pandemia: l’Omertoso.
La dottoressa Breda raccontava, infatti, che il tracciamento era in affanno a causa di chi rinunciava consapevolmente a segnalare i contatti stretti avvenuti nel periodo di incubazione del Covid.
Per l’ennesima volta, dall’inizio della pandemia, le responsabilità venivano fatte colare, senza un briciolo di vergogna, dai palazzi da dove provenivano verso il basso, come liquame.
Non una riga, di quell’articolo, si pronunciava sulle evidenti falle della sanità pubblica, manco per denunciare le banalità sotto gli occhi di tutti: che i miliardi tagliati alla salute negli ultimi anni [4], ad esempio, oltre a costare posti in terapia intensiva, hanno un prezzo elevatissimo soprattutto in termini di azzeramento della medicina territoriale, proprio quella che nell’isolamento coatto della quarantena potrebbe fare davvero la differenza, attraverso il contact tracing e la vicinanza al malato.
Confrontandomi con le esperienze vissute negli ultimi mesi da alcune compagne, trovo conferma di quanto pensavo: già dall’inizio dell’autunno in corso, il tracciamento è andato in tilt, non essendo quasi per nulla praticato dalla Azienda Sanitaria.
La stessa ASUGI, con un annuncio pubblicato sul proprio sito in data 11 novembre 2021 (il giorno successivo la diffusione dell’intervista alla dottoressa Breda), annunciava di aver assunto 12 medici con contratto di lavoro autonomo e co.co.co. (sic!) “per potenziare l’attività di prevenzione, profilassi e tracciamento” [5].
Ma la colpa non era degli Omertosi?
Omertosi o no, io sono risultato positivo a un tampone rapido il 22 novembre. A una settimana di distanza, nessuno mi ha ancora contattato per chiedermi conto dei miei contatti stretti.
Mia madre, che avevo sfortunatamente visitato proprio la sera in cui avevo iniziato a perdere la sensibilità olfattiva, si era segnalata come sintomatica, e aveva così avuto accesso a un tampone molecolare nell’arco di quattro giorni. Lo stesso aveva fatto una mia amica, con cui avevo avuto contatti ravvicinati nella finestra di probabile maggiore contagiosità.
Mia sorella e il suo ragazzo, residenti in Germania e ospiti da mia madre la sera in cui avevo cenato da lei, erano in autoisolamento da giorni. Il dottore della Guardia Medica con cui avevano cercato di confrontarsi, saputo che non risiedono in Italia, si era messo a ridere amaramente e aveva aggiunto: “tanti auguri!”.
Il mio compagno aveva ricevuto asilo da alcune amiche. Anche lui rinchiuso in una stanza, mascherine per muoversi per la casa e tamponi rapidi ogni giorno, in attesa di un qualche segno di vita da ASUGI che gli consentisse la certezza di un test molecolare e gli desse una qualche copertura per le assenze dal lavoro accumulate.
Erano questi gli omertosi di cui parlavano?
Tutte queste persone avrebbero preferito di gran lunga essere contattate dal Dipartimento di Prevenzione, per togliersi ogni dubbio e avere a disposizione gli strumenti adatti per far fronte alla situazione imprevista in cui erano incappate.
Invece, restava l’attesa.
“Guarda che a me han chiamato per fissarmi un tampone e poi basta. Non ho sentito nessuno per quasi due settimane. Nessuno mi ha chiesto come stavo, nessuno mi ha contattato per segnalare nulla, non ho manco ricevuto il provvedimento di quarantena. Mi hanno fissato il tampone e poi son spariti, completamente, non mi hanno più richiamato. Anche chi si è autosegnalato come contatto a rischio non è mai mai stato ricontattato e quando, dopo oltre una settimana, ha chiamato per chiedere se poteva fare un molecolare in privato per “liberarsi”, gli hanno detto di no, che doveva aspettare loro indicazioni“.
Era questa, l’attesa.
Una sensazione che forse le generazioni più anziane capiscono solo in parte, ma che gli ultraventenni e gli ultratrentenni della mia rete conoscono alla perfezione. È la cornice culturale in cui siamo cresciute, tutto sommato: il bilico, la precarietà che si condensa nell’attesa ansiogena di una telefonata (che sia per il colloquio di lavoro o per il tampone, poco cambia).
A questa attesa ci ho già fatto il callo, il cellulare me lo porto al cesso comunque.
Ho già fatto pace con questa attesa, e poi sto bene, ho la malattia pagata, un buco di appartamento in cui, però, ora sto da solo, un esercito di persone pronte a precipitarsi da me se avessi bisogno di medicine, di spesa, di libri o di erba buona per passare il tempo.
Ma gli altri? Ma io, se uno di questi aspetti – la salute i soldi la tranquillità i vizi – dovesse venir meno, quanto potrei reggerla, questa attesa?
Come decidere di radersi i capelli
Non lo so, ma, per come stanno le cose, direi dieci giorni.
L’attesa è rotta trascorso questo lasso di tempo dall’inizio dell’isolamento, quando mi sono ormai messo nell’ottica che le giornate di malattia le trascorrerò al telefono, nella speranza di intercettare qualcuno che abbia il potere di programmarmi un tampone di controllo (e magari di emettere il certificato di quarantena, che ancora non ho ricevuto).
Mi sto armando intellettualmente allo scontro con l’apparato burocratico, quando mi suona il telefono: a sorpresa, è il dipartimento di prevenzione (dieci giorni d’attesa: non male, visti i presupposti, rifletto sarcastico).
La persona che mi ha telefonato è estremamente cortese e attenta, o forse sono pure io che – dopo diversi anni passati a sopravvivere lavorando nella jungla dei call center – non posso fare a meno di empatizzare con il mio interlocutore, conoscendo alla perfezione la sensazione di trovarsi davanti al computer, con una cuffia, molta noia e nessuno strumento adeguato per rispondere compiutamente alle domande di chi sta all’altro capo del telefono.
Mi chiede come sto (è la prima volta da dieci giorni che la sanità pubblica se ne preoccupa).
I CCCP mi inondano il cervello e sono tentato di rispondere che non studio, non lavoro, non guardo la tv, eccetera eccetera.
In realtà, a lavorare ho un pochino ricominciato, a causa del beffardo contrappasso di autosfruttamento riservatomi da un mestiere che mi permetterebbe di fare un po’ quel cazzo che voglio, quindi mi risolvo a dire “io sto bene”. In questo caso, è almeno parzialmente vero: i sintomi influenzali sono scomparsi da oltre una settimana e ho anche iniziato a recuperare gusto e olfatto.
Dopo dieci giorni di oblio, è davvero una formalità questa telefonata: lo sappiamo entrambi.
Vive da solo?
No, non vivo da solo, di solito: vivo con il mio compagno, ma abbiamo scelto di trascorrere l’isolamento separatamente… è una persona a rischio.
Mi rendo conto in quel momento di parlare con un medico, una persona che può forse fugare qualcuno dei molteplici dubbi che ci attanagliano dall’inizio della pandemia; mi ritorna pure alla mente mio moroso: “usala, la mia diagnosi, usala sempre, se ci può far ottenere qualche informazione in più, ché almeno ‘sto stigma di merda serva a qualcosa“.
Sa, è sieropositivo, aggiungo.
Silenzio, all’altro capo.
Il solito silenzio.
Cristo, questo qua – come sempre – non sa di che cazzo parlo.
Come il medico di base del mio compagno, l’unico con cui era riuscito a intrattenere un confronto, già a marzo del 2020: non uscire per nessun motivo, ripeto, non uscire per nessun motivo! Fatti portare la spesa a casa! Usa i guanti e la mascherina, se proprio devi abbandonare la base!
Ve le ricordate, le introvabili mascherine, un anno e mezzo fa?
Ve lo immaginate, il conseguente stato d’animo generato da queste parole in una persona, come tutti, già bombardata dal terrorismo mediatico, dai bollettini di guerra, dallo #stateacasa?
All’epoca, dividevamo una stanza di pochi metri quadri in una casa malandata (lo squat, per gli amici) e lì ci eravamo rintanati.
Poi erano arrivate le linee guida del Ministero della Salute: “le persone con HIV in trattamento antiretrovirale efficace, con un numero di CD4 maggiore di 500 e con viremia controllata, per i dati oggi a disposizione, se contraggono il Covid-19 non hanno un rischio di peggior decorso rispetto a una persona HIV-negativa” [6].
Da lì in poi, avevamo mangiato la foglia e avevamo iniziato ad autogestirci, a organizzare pic-nic clandestini settimanali e a dare supporto concreto alle compagne con cui avevamo iniziato a organizzare i gruppi mutualistici di aiuto.
Le linee guida del Ministero parevano messe in discussione, qualche mese dopo, dai primi studi organici sul tema [7-8], ma i dati disponibili non chiarivano nessuno dei nostri interrogativi.
Il cuore della faccenda erano quelle sei parole, buttate giù non a caso dai funzionari della sanità pubblica: “per i dati a nostra disposizione“.
Significava che non ce n’erano, di dati utili: è un’emergenza, bellezza, la priorità non puoi essere tu.
La dottoressa che seguiva da anni la persona con cui dividevo casa e vita, era scomparsa.
La stessa professionista che, fino a un attimo prima, poteva sempre essere consultata, con cui mio moroso aveva discusso di terapie, di sesso e di droghe, che anch’io avevo conosciuto e di cui conservavo il numero di telefono e la mail, era stata inghiottita dalle corsie della terapia intensiva.
È davvero un’emergenza, quella che stiamo vivendo, una di quelle belle emergenze permanenti a cui il neoliberismo ci ha abituati: a 22 mesi di distanza dal presunto inizio della pandemia, nulla è cambiato; il “mio” compagno incrociava la “sua” dottoressa per 10 minuti al massimo, una volta ogni 3 o 4 mesi, il tempo di leggere le analisi periodiche e di scappare.
Al telefono e alle mail non risponde più.
Il silenzio, in realtà, è durato qualche attimo appena.
Torno al telefono.
Soppeso la voce della persona che conversa con me e cerco di indovinarne l’età e i possibili riferimenti culturali: probabilmente si sta immaginando aloni viola, fiumi di sostanze e affollate orge frocie.
Magari.
Riprendo il filo.
Dopo otto giorni di isolamento, nessun sintomo e una serie quotidiana di test antigenici negativi, abbiamo concluso ragionevolmente che se l’è scampata. Ma sa, preferirebbe averne la certezza e avere la copertura del periodo di assenza dal lavoro.
Dico così al mio cortese interlocutore.
Lui si barcamena, obietta che non può fare un certificato di quarantena retroattivo.
Gli faccio notare con educazione che sarà la stessa soluzione che adotteranno con me e aggiungo che così facendo disincentivano le persone dall’assumere comportamenti responsabili: e chi se lo può permettere, l’autoisolamento, se non mi coprite manco la malattia?
Mi ascolta, si arrende, mi mette in attesa: mi informo (e il mio istinto da telefonista mi dice che sta andando davvero ad informarsi, e che un po’ la situazione se l’è presa a cuore).
Resto appeso ad ascoltare il sottofondo musicale, fino a quando la comunicazione non riprende: sì, ok, si può fare, ma lo devo mettere in quarantena altri quattro-cinque giorni, oppure gli fisso un molecolare e aspettiamo i risultati, ma i tempi son più o meno quelli, più uno-due giorni per le risposte.
Mi arrendo io, ora. Non si preoccupi, si arrangerà con ferie e permessi.
Il cortese interlocutore non obietta nulla e mentalmente lo ringrazio per questo, perché sto davvero cominciando a esaurire ogni verve polemica.
Ci lasciamo con qualche domanda di routine (è vaccinato? ha idea di dove possa aver contratto la malattia?) e nessun vero e proprio tracciamento; mi preoccupo io di segnalare mia madre: la contatteremo subito, non si preoccupi (e così, in effetti, sarà).
Ne esco con un tampone di controllo prenotato fra qualche giorno e con la certezza che quanto riferitomi dai compagni è vero.
“Ma ASUGI te ga za ciamà per el secondo tampon, che me son perso?” “Sì, grazie a F. dio can. La baba la ga ciamada per dirghe che el suo tampon iera negativo e ela ghe ga pianto el morto che no i me gaveva ancora ciamado…“.
“Oh teniamoci in contatto e ricordiamo alle autorità sanitarie la nostra rispettiva esistenza: passaparola e rompere i coglioni, se ne esce solo così“.
Andiamo bene.
Note:
[1]Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina